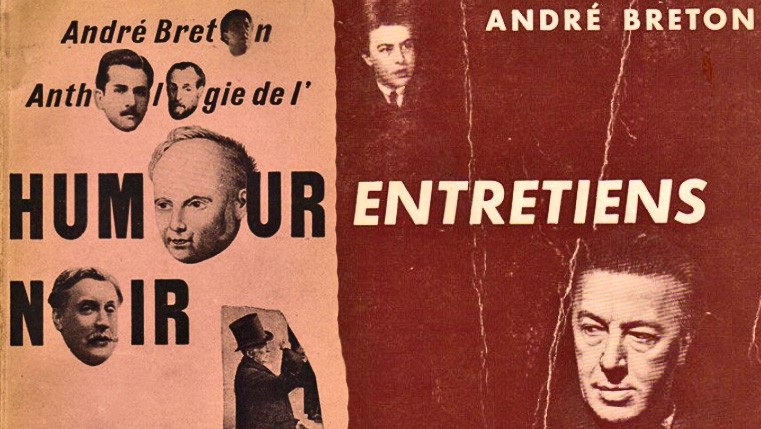“Ma quando l’ho incontrato per la prima volta, era dicembre del 1926. Sebbene fossero passati appena due anni da quella sua prima lettera piena di entusiasmo, Breton sembrava già aver perso molte delle sue illusioni, della sua fiducia in ciò che attendeva il surrealismo. Gli scrissi appena arrivato a Parigi, e lui mi diede un appuntamento tramite un ‘pneumatico’. Mi trovai da lui la sera del 23 dicembre; lo trovai da solo in quello strano studio, in cima a un’alta costruzione a Montmartre, all’angolo tra rue Fontaine e Place Blanche, dove si era trasferito quattro o cinque anni prima e dove avrebbe trascorso tutta la sua vita, in quella sorta di torre d’osservazione impossibile, che nel corso dei decenni si sarebbe trasformata in un museo di meraviglie sempre più ricco e fantastico. In mezzo a quei quadri di Picasso, di Chirico, di Max Ernst, a quelle maschere oceaniche e feticci, a quegli strani oggetti che sembravano essersi materializzati direttamente, emersi di colpo dalla densa profondità del sogno, mi trovai seduto di fronte a un uomo la cui testa imponente e straordinaria suggeriva una predisposizione alla dominazione sugli altri, ma la cui fronte solenne e autorevole era ombreggiata da preoccupazioni che solo parzialmente mi era dato di cogliere.”
“Avevo già letto il suo scritto Légitime Défense – uno dei pochi testi che, a conti fatti, in retrospettiva, ha indubbiamente giocato un ruolo cruciale e lasciato un segno indelebile nella mia determinazione – e sapevo così a quali difficoltà si fosse imbattuto Breton, dovendosi scontrare nel realizzare la sua ferma e completamente meditata decisione di includere il surrealismo nel marxismo (o il marxismo nel surrealismo), concretamente: di diventare membro del Partito Comunista senza rinunciare al diritto di continuare, su un piano non politico, l’esplorazione e la sperimentazione che fino a quel momento erano state un territorio specifico del surrealismo, e che, in fondo, lo avevano portato a quella decisione, dopo averne tratto le conclusioni dialettiche che si imponevano al termine di un onesto e rigoroso esame delle loro condizioni e conseguenze reali. Ma non potevo sapere che, in quel momento, proprio quell’autunno, nella sua vita fosse passata Nadja, il cui incontro lo aveva segnato in modo del tutto diverso, ancora più profondamente di quanto avessero fatto in gioventù gli incontri con Valéry, Apollinaire e, soprattutto, Vaché. Forse, in quel momento, stava già iniziando a scrivere il suo libro su Nadja, per il quale – non sono certo mosso da una preferenza soggettiva quando penso che alla fine sia rimasto il più bello di tutti i libri di Breton. Ricordo, vagamente, che mi parlava di un libro che stava per scrivere, ma per il quale non aveva ancora trovato il tono. Era probabilmente Nadja, che sarebbe apparsa nel 1928…”